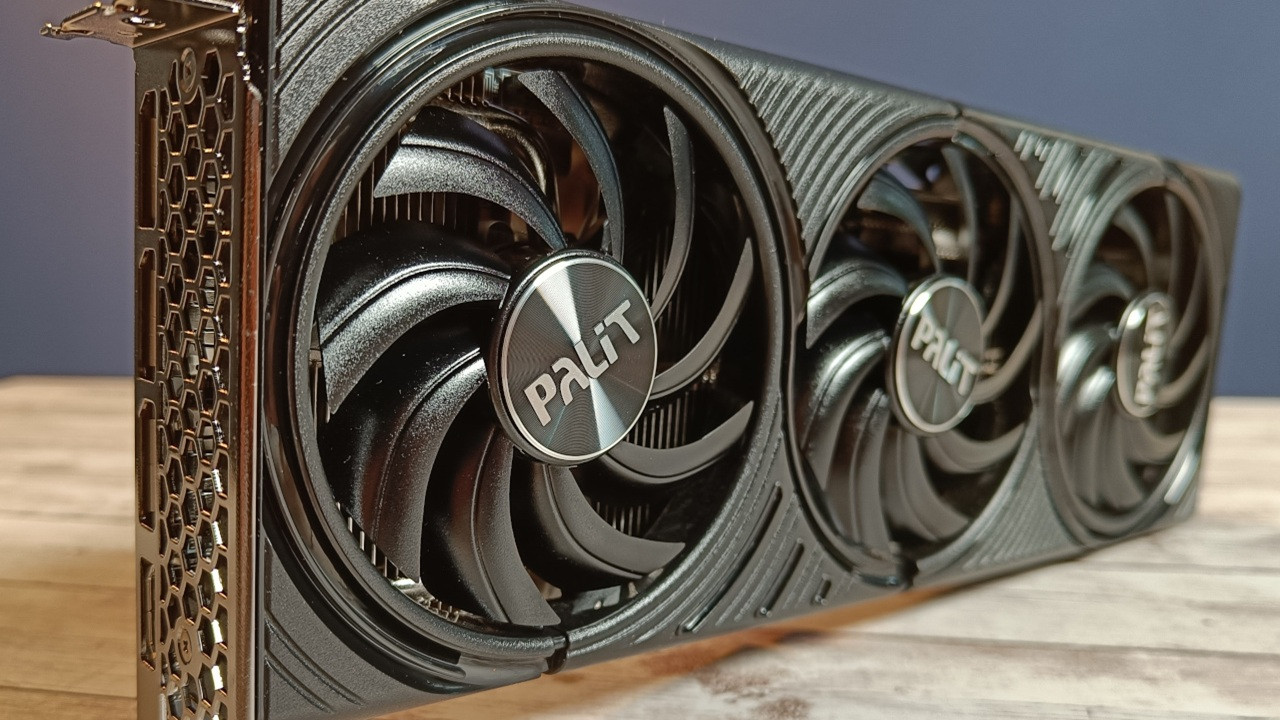Noia, e no, non ho detto gioia, ma noia, noia, noia. La maledetta noia che cantava Franco Califano è una delle esperienze più universali al mondo: adulti e adolescenti, bambini e anziani, ricchi e poveri, analfabeti e colti – tutti, ma proprio tutti, si annoiano. E sebbene sia considerata una sensazione negativa, una sorta di “vuoto” della mente, le cose non stanno proprio così. Oggi, in capo a decenni di ricerca sulla materia, sappiamo infatti che la noia è per certi versi “necessaria” al nostro cervello per essere più efficiente e gestire al meglio il flusso di informazioni e il carico di lavoro cui è sottoposto. L’aneddotica non manca. Pensate per esempio ad Albert Einstein, che gettò le basi della teoria della relatività speciale – uno dei pilastri della fisica moderna – mentre si annoiava al suo posto di travetto all’Ufficio brevetti di Berna. O a Italo Svevo, che lavorò per diciotto anni alle casse della Banca Union di Vienna dando alle stampe, nel frattempo, quei grandi capolavori che sono Una vita e Senilità. Suggestioni, certamente, che anche se non bastano ad affermare l’esistenza di un nesso causale tra noia e creatività, per lo meno potrebbero aiutarci a demonizzarla meno e renderla più tollerabile. Lasciamo allora da parte le storielle ispirazionali e proviamo a capire cos’ha da dire la scienza in proposito.
Noia, una definizione difficile
Molto prima di essere oggetto di studi clinici, la noia era già stata esaminata (e condannata) da filosofi e pensatori di ogni epoca. Seneca, per esempio, pensava che la noia fosse mal tollerata perché “la natura della mente umana è di essere attiva e incline al movimento”. Secoli dopo, il filosofo tedesco Arthur Schopenauer la definì come “una calma priva di significato”, assimilandola, per l’appunto, alla prova che l’esistenza stessa fosse fondamentalmente priva di significato. Ancora più tardi, nel secolo scorso, Theodor Adorno la interpretò come un fenomeno materiale, piuttosto che esistenziale, “una funziona della vita vissuta sotto la compulsione a lavorare”, e fu tra i primi a suggerirne un ruolo positivo nell’esprimere l’insoddisfazione umana rispetto ai regimi repressivi dell’economia capitalista. Una delle definizioni moderne e più “scientifiche” è al negativo, e accosta la noia “all’esperienza negativa di desiderare qualcosa ma di non essere in grado di impegnarsi in un’attività soddisfacente”. Al di là di queste definizioni, comunque, la verità è che ancora non sappiamo quali siano le cause profonde della noia: alcune attività ci annoiano perché non sono abbastanza stimolanti, altre perché troppo complicate, altre ancora perché ripetitive, e altre ancora perché percepite come prive di significato, come illustrò l’antropologa Yasmine Musharbash in un articolo pubblicato nel 2007 sulla rivista American Anthropologist, risultato di uno studio condotto su una comunità di aborigeni australiani. Ma d’altronde è vero anche il contrario, come discusso da due psicologi in un altro lavoro pubblicato nel 2013 sulla rivista Behavioral Sciences: a volte possono essere noiose attività che hanno molto significato – leggere una favola al proprio figlio, per esempio – o non essere affatto noiose attività apparentemente prive di significato, come per esempio risolvere uno schema di parole crociate. Insomma, una grande confusione.
Cervello annoiato
“La rete cerebrale – spiegano su The Conversation Michelle Kennedy e Daniel Hermens, ricercatori nel campo della salute mentale alla University of the Sunshine Coast – è un sistema di regioni interconnesse che lavorano insieme per supportare funzioni diverse. Possiamo pensarla come una città in cui i diversi quartieri (le regioni del cervello) sono connessi da strade (i percorsi neurali) e tutto funziona in modo sincronizzato per consentire all’informazione di viaggiare in modo efficiente”. E la noia è un particolare stato cerebrale in cui si “disattivano” alcuni quartieri e si intensifica la vita in altri. Supponiamo, per esempio, di aver cominciato la visione di un film: in questo momento, il nostro cervello fa sì che la rete dell’attenzione dia priorità alle immagini che scorrono sullo schermo e che filtri via le distrazioni. Se il film non ci piace, l’attività della rete dell’attenzione diminuisce – e cominciamo a perderci battute e scene della pellicola – e contemporaneamente si attiva un altro circuito, il cosiddetto sistema della condizione di default, in cui l’attenzione si “sposta” verso l’interno, accendendo una sorta di modalità introspettiva.
Ecco, lo stato di noia, lungi dall’essere una “pausa” del cervello, coinvolge in verità queste e altre regioni cerebrali, che lavorano di concerto. Oltre a quelle già citate, è da menzionare per esempio l’insula, un centro fondamentale per l’elaborazione sensoriale ed emotiva: questa regione si attiva nel momento in cui rileva segnali corporei interni – “mi sto annoiando” – che indicano che il film non è più coinvolgente, un fenomeno noto come enterocezione. Entra poi in gioco anche l’amigdala, una sorta di “sistema d’allarme” del cervello, che elabora le informazioni emotive e svolge un ruolo importante nella formazione di ricordi emozionali. Durante lo stato di noia, questa regione, insieme alla corteccia prefrontale ventromediale, ci spinge a cercare altre attività, più stimolanti (non sempre con successo, c’è da ammettere).
Luci e ombre
Poco sorprendentemente, la noia è stata collegata a una serie di comportamenti problematici. Diversi studi, per esempio, hanno mostrato che la propensione alla noia è associata a una maggiore propensione a comportamenti a rischio, tra cui gioco d’azzardo, abuso di sostanze, binge-eating e addirittura – in casi più rari – comportamenti autolesionistici. Non solo: è stata anche associata a risultati scolastici e lavorativi inferiori, a problemi di salute mentale, a un maggior rischio di insorgenza di ansia e depressione. Ma, fortunatamente, c’è anche altro, che ha a che fare con la sovrastimolazione tipica della nostra epoca. “La stimolazione costante – continuano i due scienziati – può essere molto costosa a livello cerebrale. Quando siamo costantemente stressati a causa dell’acquisizione continua di nuove informazioni o di dover passare da un’attività all’altra, il sistema nervoso simpatico può esserne sopraffatto e farci provare uno stato di sovreccitazione che può aumentare il rischio di ansia. In questo senso, lo stato di noia può considerarsi una sorta di ‘reset’ per il nostro sistema nervoso simpatico”. Non solo: concedere alla nostra mente una “sana dose” di noia sembra abbia un effetto nell’aumento della creatività, dell’indipendenza di pensiero, nella ricerca di altri interessi rispetto agli stimoli esterni e addirittura nella rottura degli schemi di “gratificazione istantanea” che portano a dipendenze come l’uso compulsivo dello smartphone. E no, non ho detto gioia.