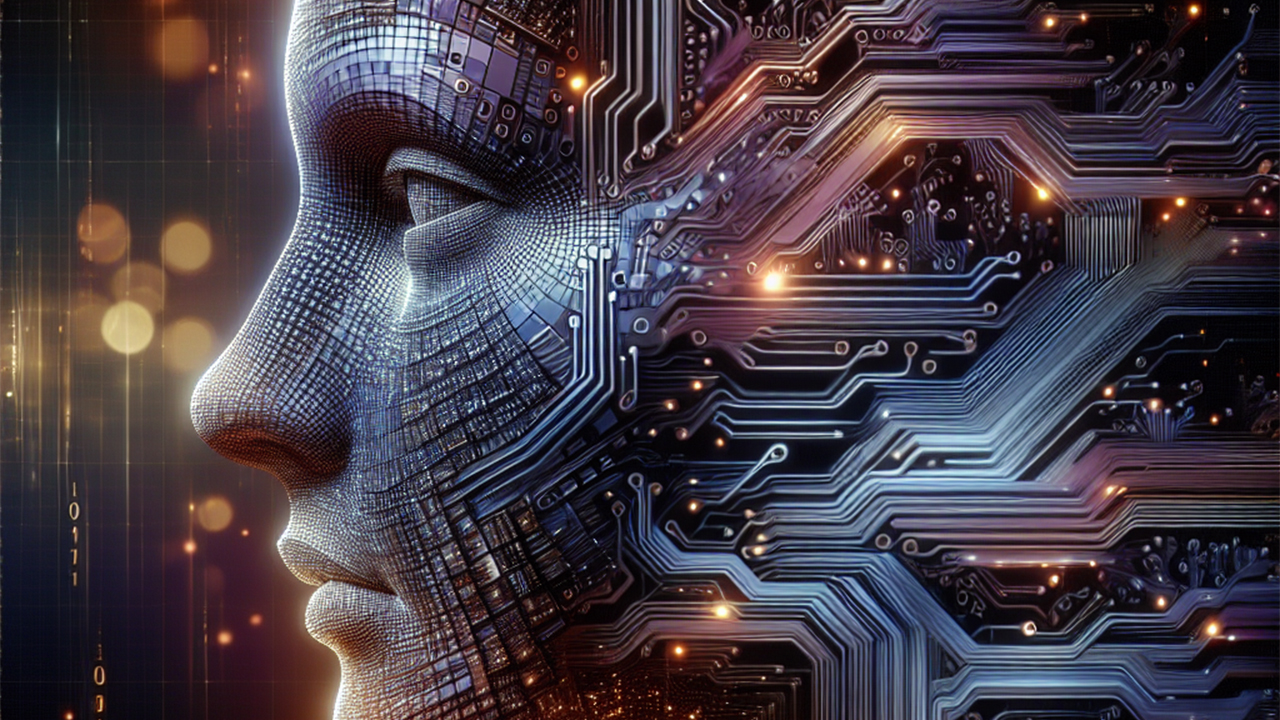Mancano meno di due mesi alla Cop30, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in programma a Belém, in Brasile, dal 10 al 21 novembre 2025, ma i Ventisette non hanno ancora trovato un accordo sugli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra da raggiungere entro il 2035 e il 2040. Sembra assurdo, ma nel corso della riunione del 17 settembre, a Bruxelles, i ministri europei dell’Ambiente e del Clima hanno deciso di non decidere e rinviando la scelta al Consiglio europeo di ottobre, segno che le divisioni interne richiedono ormai un intervento dei capi di Stato e di governo. A generare mggiori discussioni sono i Nationally determined contributions (Ndc), ovvero le promesse, ancora prima dei piani, di riduzione delle emissioni che andrebbero aggiornate ogni cinque anni come previsto dall’Accordo di Parigi. Un momento cruciale, dunque, perché si decide oggi quali impegni l’Unione europea adotterà per il prossimo futuro. La presidenza danese del Consiglio, che aveva inizialmente sperato di raggiungere un accordo politico entro settembre, sta ora esplorando compromessi che rischiano di indebolire la posizione europea, come ridurre le ambizioni e gli obiettivi o addirittura separare completamente i target del 2035 da quelli del 2040, spezzando la coerenza della strategia climatica di lungo termine.
Clima, su cosa sono divisi gli stati europei
Il disaccordo riguarda soprattutto l’entità del taglio – in gergo, mitigazione – e la velocità della transizione verso un’economia a emissioni nette zero. I paesi europei “meno ambiziosi sul clima” – tra cui Repubblica Ceca e Ungheria, ma con il sostegno tattico di Italia e Germania su alcuni aspetti procedurali – vogliono riduzioni “vicine al 66% delle emissioni di gas serra” rispetto ai livelli del 1990, con una traiettoria lineare tra il 2030 e il 2050 che distribuisca lo sforzo in modo uniforme nel tempo. Questa posizione si scontra con quella dei paesi “più ambiziosi”, principalmente nordici e dell’Europa occidentale, che puntano a un obiettivo per il 2035 tra il 66% e il 72,5%, ma soprattutto vogliono accelerare le riduzioni nel primo periodo per avere maggiori margini di manovra successivamente. La differenza può sembrare tecnica, ma ha implicazioni enormi: accelerare ora significherebbe chiudere più centrali a carbone e gas nei prossimi dieci anni, trasformare i sistemi di trasporto e di riscaldamento, investire massicciamente in rinnovabili quando i costi del capitale sono ancora elevati dopo anni di inflazione.
La Commissione europea ha proposto a luglio 2025 una riduzione del 90% delle emissioni nette entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990, un obiettivo che già rappresentava l’estremità meno ambiziosa dell’intervallo del 90-95% raccomandato dal Comitato scientifico consultivo europeo sui cambiamenti climatici (Esabcc). Per rendere politicamente accettabile questa proposta, la Commissione ha introdotto una novità storica: per la prima volta ha consentito l’uso di crediti di carbonio internazionali nel raggiungimento di un obiettivo di riduzione delle emissioni. Questi crediti finanziano progetti in altri paesi, spesso in via di sviluppo, che riducono o assorbono CO2, e ogni tonnellata così evitata può essere conteggiata come parte della riduzione europea. Il loro utilizzo è però limitato al 3% dell’obiettivo dell’Ue e solo nel periodo 2036-2040. Il commissario europeo per il Clima, Wopke Hoekstra, ha precisato che i crediti dovranno essere di alta qualità, verificabili e addizionali, cioè legati a riduzioni che altrimenti non sarebbero avvenute. Nonostante queste garanzie, molti esperti temono che la possibilità di ricorrere a crediti esterni possa però indebolire gli sforzi dei paesi europei nel ridurre le emissioni sul proprio territorio.
Le conseguenze economiche delle politiche climatiche sono al centro delle preoccupazioni dei paesi che resistono a obiettivi più ambiziosi. Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia sostengono che il sistema europeo di scambio delle emissioni (Ets) – che fa pagare alle aziende ogni tonnellata di CO2 emessa – stia penalizzando la competitività europea rispetto a concorrenti come la Cina che non hanno vincoli ambientali comparabili. Questi paesi citano dati del settore industriale: il comparto automobilistico ha registrato un calo degli ordini del 20% su base annua. Un rapporto del think tank Cep di Berlino, citato dai paesi del blocco meno ambizioso, sostiene che un obiettivo del 78% di riduzione entro il 2040 sarebbe finanziariamente più sostenibile del 90-95% proposto dalla Commissione.
Eppure le conseguenze si fanno sempre più estreme e urgenti
L’incapacità europea di trovare un accordo arriva in un momento particolarmente critico, non solo per le tempistiche della Cop30 ma anche per i segnali sempre più allarmanti degli impatti dei cambiamenti climatici sul nostro continente. Un nuovo studio pubblicato mercoledì 17 settembre dall’Imperial College di Londra e dalla London school of hygiene & tropical medicine stima che il riscaldamento globale ha causato circa 16.500 decessi nelle città europee durante l’estate 2025, su un totale di 24.400 morti dovute al caldo in 854 città analizzate. Gli scienziati hanno utilizzato modelli climatici per stimare che il riscaldamento globale ha reso le temperature in media 2,2 gradi Celsius più alte nelle città europee tra giugno e agosto, con picchi fino a 3,6 gradi in alcune aree. Il caldo estremo ha provocato in Europa quasi 16.500 morti in più del previsto, di cui circa il 70% attribuibile al cambiamento climatico causato dall’uomo. Secondo gli esperti, il riscaldamento globale ha triplicato i decessi per caldo rispetto a un mondo senza emissioni. Roma guida la classifica delle città più colpite, seguita da Barcellona, Milano e Parigi.