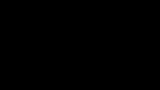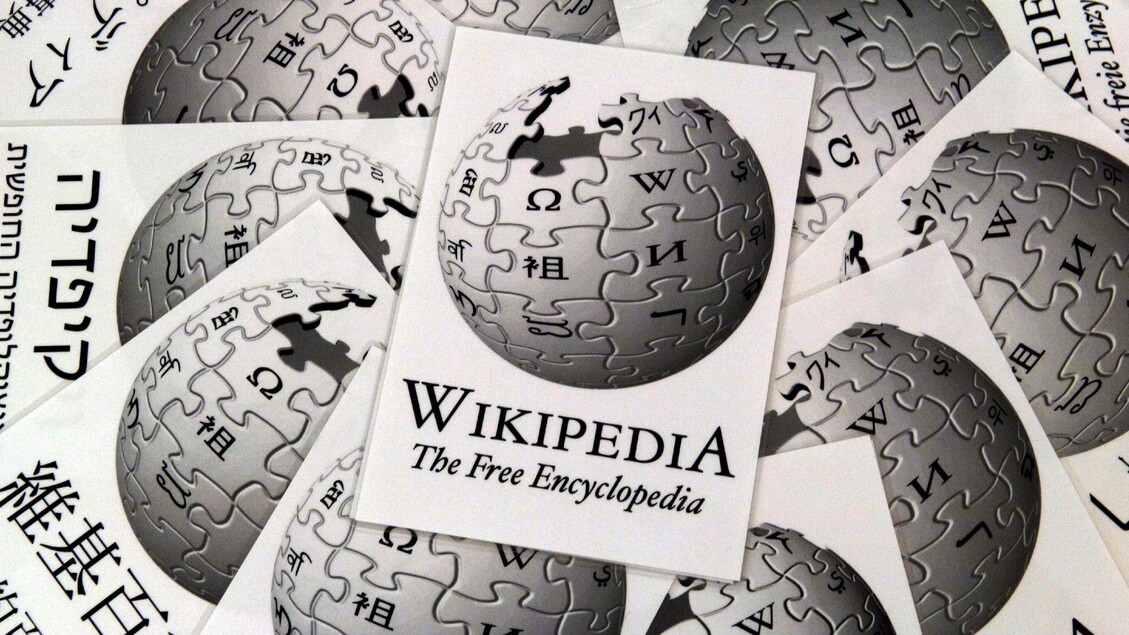Arriva lo stop dei giudici al progetto del ponte sullo Stretto di Messina. Mercoledì 29 ottobre la Corte dei conti, l’organo che vigila sulla spesa pubblica dello Stato, ha bocciato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto, negando il visto alla delibera approvata il 6 agosto dal Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), il gruppo di ministri che decide quali grandi opere finanziare. Senza questo visto di legittimità, il governo non può procedere all’erogazione dei fondi pubblici previsti (13,5 miliardi di euro) e l’avvio dei lavori resta formalmente bloccato. I giudici contabili renderanno noti nei dettagli i motivi del rifiuto entro 30 giorni.
Quali sono i problemi sollevati dai giudici e le risposte che il governo non ha fornito
I dubbi erano emersi già il 24 settembre, quando la Corte aveva chiesto spiegazioni al governo, al ministero delle Infrastrutture e agli uffici di Palazzo Chigi su questioni che rimanevano poco chiare riguardo il ponte sullo Stretto. Le domande riguardavano punti cruciali: i conti economici tornano davvero? Ci sono abbastanza soldi per tutti gli anni necessari ai lavori? Le previsioni sul traffico sono realistiche? Il progetto rispetta le norme ambientali e antisismiche? Tra tutti, il nodo più delicato — e probabilmente quello che ha maggiormente preoccupato la Corte – riguardava le regole europee sugli appalti pubblici.
La direttiva dell’Unione europea 2014/24, valida in tutti i paesi membri, stabilisce che se i costi di un’opera pubblica aumentano di oltre il 50% rispetto al contratto iniziale, bisogna indire una nuova gara d’appalto aperta a tutte le imprese europee. Nel caso del Ponte, il contratto originale del 2006 prevedeva circa 4,6 miliardi di euro, mentre oggi la stima dei costi arriva a 13,5 miliardi, quasi tre volte tanto. Ciò significa che, secondo la normativa europea, il governo avrebbe dovuto avviare una nuova gara internazionale, invece di riattivare semplicemente il vecchio contratto con Eurolink, il consorzio incaricato della costruzione. Eurolink riunisce tre grandi imprese: l’italiana Webuild, principale società del settore con opere in tutto il mondo; la spagnola Sacyr, che ha partecipato all’ampliamento del Canale di Panama; e la giapponese Ihi, specializzata in ponti sospesi e strutture in acciaio. Il consorzio aveva vinto la gara nel 2006, ma il progetto era stato cancellato nel 2013 durante la crisi economica europea, quando l’Italia dovette ridurre drasticamente le spese pubbliche, per poi essere riattivato nel 2023.
Dubbi su dubbi
Nel loro documento tecnico di 23 pagine diffuso a fine settembre, i giudici avevano espresso anche altri dubbi. Un punto controverso riguardava la procedura Iropi (Imperativi requisiti di interesse pubblico prevalente), uno strumento giuridico che consente ai governi di realizzare opere anche se hanno un impatto ambientale negativo, quando sussiste un interesse pubblico superiore.
Il governo italiano ha applicato questa procedura al ponte, arrivando persino a classificarlo come opera di interesse militare per aggirare alcuni vincoli. I giudici hanno chiesto di verificare se questa scelta rispetta le direttive europee sull’ambiente, in particolare la direttiva Habitat, che tutela gli ecosistemi naturali, e la Via (Valutazione di incidenza ambientale), che valuta l’impatto delle opere sulla natura. La Corte ha inoltre voluto chiarire se il governo abbia effettivamente discusso con la Commissione europea a Bruxelles l’utilizzo di questa procedura eccezionale, visto che i contatti sono iniziati soltanto a giugno 2025, quando il progetto era già stato approvato.