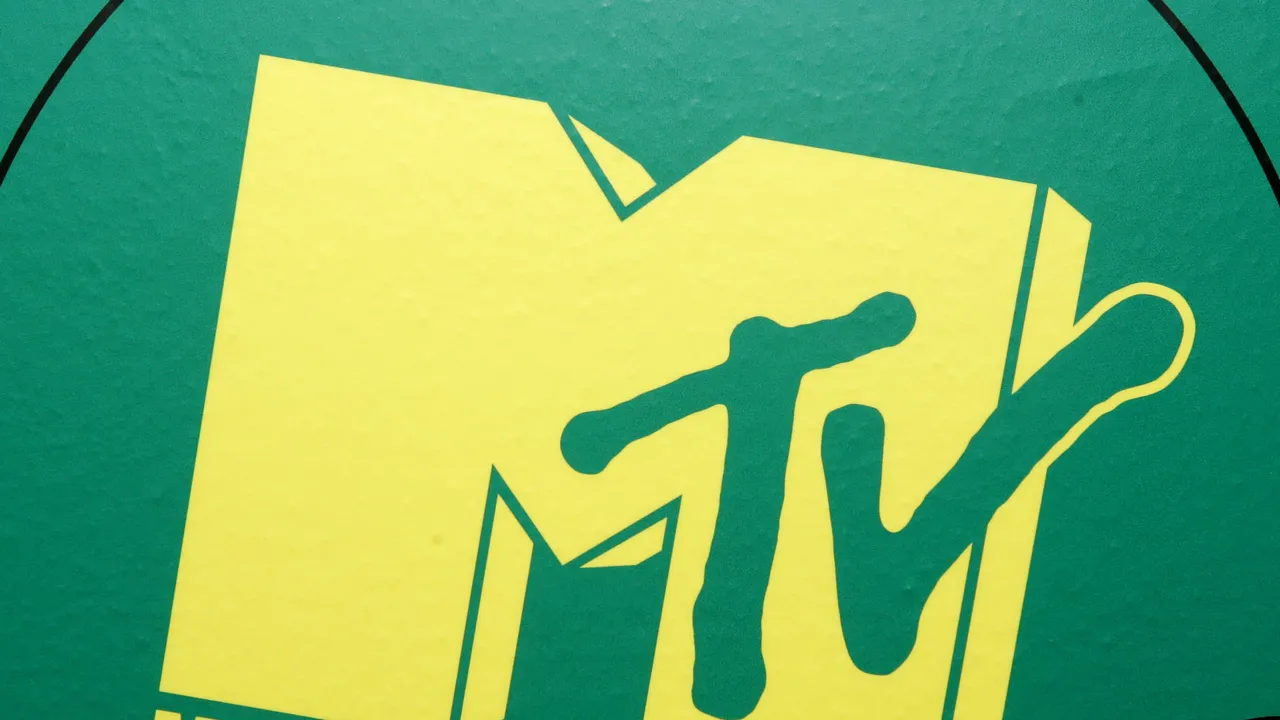Forse l’aria nel cinema italiano sta cambiando, almeno per quanto riguarda le logiche produttive, poi agli spettatori l’ardua sentenza. Negli ultimi dieci anni si è fatto un gran parlare della necessità di dare un seguito alle iniziative, isolate, di giovani cineasti che si sobbarcavano l’arduo compito – spesso anche dal punto di vista economico – di proporre film di genere in una chiave nuova per rilanciare una parte da lungo sopita della nostra industria.
Una generazione di cineasti dal raggio molto ampio, paragonabile ai movie brats della New Hollywood, cresciuti con gli occhi e la testa piene di tanto cinema e dunque naturalmente predisposti a rielaborarlo, prima come appassionati e poi come professionisti. In capo a questo movimento c’è naturalmente Gabriele Mainetti, che è arrivato prima di tutti e che ha continuato ostinatamente su questa strada, cercando una congiunzione tra piano nazionale e internazionale che legittimasse la sua idea. Base di partenza fondamentale, irrinunciabile e sempre visibile, nonostante i cambiamenti.
L’autore romano parte da una visione postmoderna del nostro bagaglio cinematografico per poi spiazzare con i generi, dal cinecomic al gongfu, cercando di porsi in questo senso meno freni possibili e provando a tessere una rete affine alla sua visione anche grazie alla creazione della Goon Films. Ora sembra che qualcosa stia girando per il verso auspicato da Mainetti, basta dare un’occhiata ai titoli italiani proposti agli ultimi festival di Cannes e Venezia, appena accanto ai grandi nomi, e a chi li sostiene.
Partiamo dalla Croisette, dove nella sezione Un Certain Regard troviamo Francesco Sossai e il duo Matteo Zoppis e Alessio Rigo De Righi, rispettivamente Le città di pianura e Testa o Croce?. Nel primo caso parliamo di una pellicola, prodotta da Lucky Red, pensata nel nome della contaminazione e della rielaborazione immaginifica e che trova la sua straordinaria metafora in una Pianura Padana che da non luogo si fa contenitore di un mondo che va dall’America al Giappone, in cui un trio da due epoche diverse trova il modo di capirsi. Una visione totalmente postmoderna in cui si rilegge il cinema italiano – Il Sorpasso in modo particolare – e si guarda oltre confine, puntando ad atmosfere nordeuropee.
Nel secondo caso c’è una coppia di autori che già con il loro primo film aveva chiarito di avere una visione quasi letteraria, saggistica, del cinema, attraverso cui indagare il rapporto tra mito e realtà. Ecco perché la scelta di destrutturare il western, proprio il genere che nella cultura occidentale è stato quello che meglio di tutti ha gettato le basi per lo studio della mitopoiesi al cinema e non solo. Il titolo, prodotto tra gli altri da Rai Cinema, con un’idea di narrazione a doppio binario crea un perfetto meccanismo di continua smentita di ogni archetipo, maschera o passaggio per rigettare completamente la patina fiction e farsi strada fino al nucleo semantico della questione. “Nella Tuscia si può fare il western, se si accetta che Buffalo Bill Cody è solo un cantastorie”.
Un genere particolare e difficilissimo
Il genere che, però, si sta cercando di fare da noi in maniera più seria e convinta è l’horror. Una cosa per nulla facile perché da una parte il grande pubblico si è disabituato a vederlo e a considerarlo come cinema di largo consumo, mentre dall’altra c’è anche una difficoltà oggettiva dei professionisti di settore a pensarlo e metterlo in scena in modo spettacolare. Ecco perché Paolo Strippoli si è rivelato il nome più spendibile, avendo già lavorato con un target internazionale e avendo la conoscenza e la credibilità per poter alzare il livello.