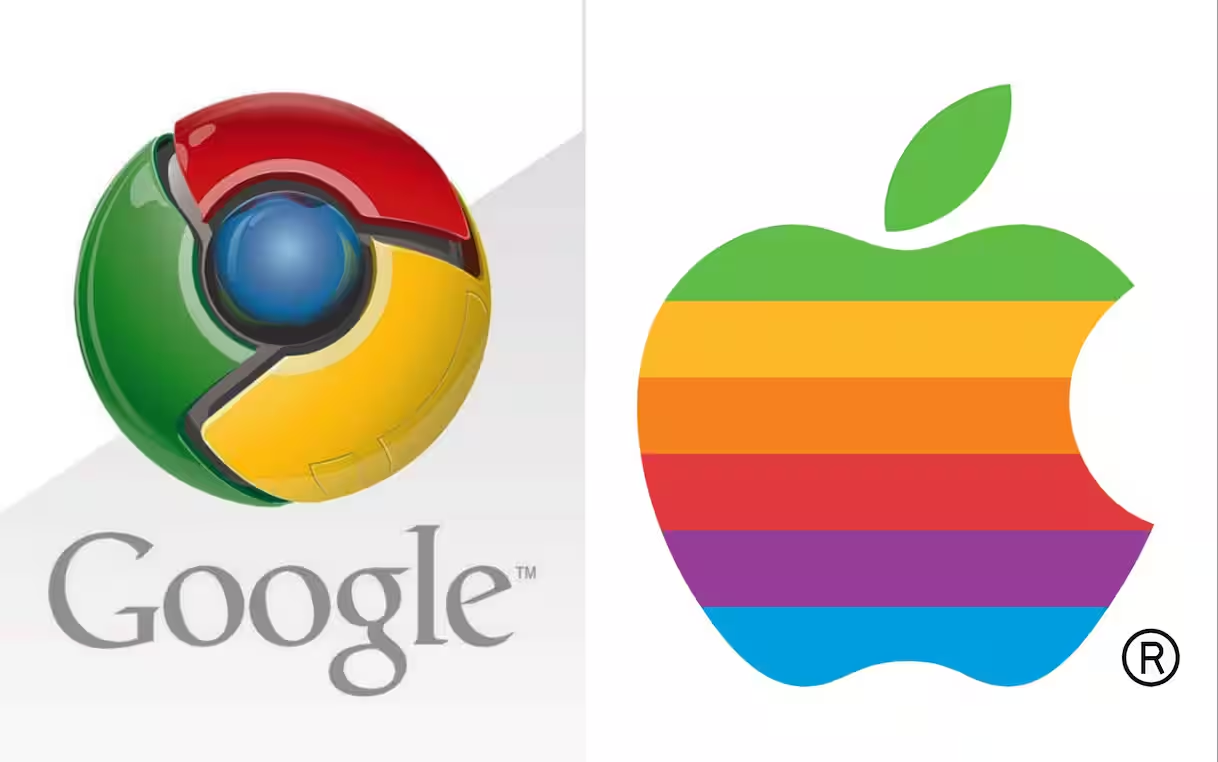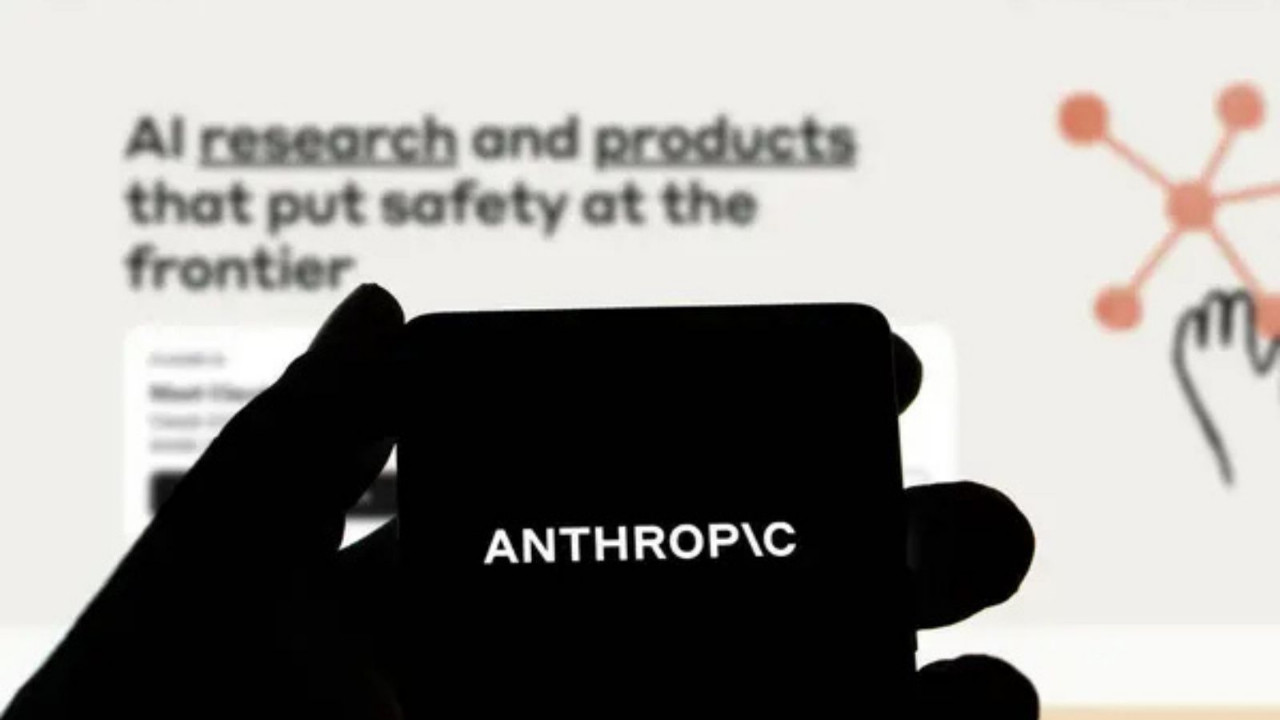Il rapporto degli italiani con l’informazione sta attraversando una fase di mutazione profonda, una transizione che emerge con nitidezza dai dati presentati al Brand Journalism Festival 2025 da una ricerca condotta da Ipsos. Ne deriva il ritratto di un Paese che non si limita a mostrare stanchezza verso la politica e i media, ma sembra muoversi in un terreno complesso, fatto di disorientamento, diffidenza e ricerca di nuovi riferimenti.
Disaffezione politica e informativa
La partecipazione politica appare indebolita: un 11% degli intervistati segue la politica senza vero interesse, spesso in modo distratto, mentre cumulativamente il 37% dichiara di non seguirla affatto, arrivando in alcuni casi a provare fastidio o addirittura disgusto quando l’argomento emerge nella conversazione pubblica
Il tempo dedicato all’informazione quotidiana si distribuisce in modo diseguale: da un lato rimangono coloro che riservano più di un’ora al giorno all’aggiornamento, dall’altro cresce il numero di chi si limita a pochi minuti o rinuncia completamente a informarsi, alimentando un divario sempre più marcato tra cittadini coinvolti e cittadini ai margini del dibattito
Nonostante la crisi di credibilità che colpisce i media tradizionali, la televisione conserva un ruolo centrale nel panorama informativo. Su politica, economia, attualità e cronaca (rispettivamente 60%, 47%, 63% e 64% degli intervistati) continua a rappresentare la principale fonte di aggiornamento, mentre internet si è radicato in modo trasversale, soprattutto tra i giovani, modificando i percorsi attraverso cui le persone costruiscono le proprie opinioni
Anche la fiducia si muove lungo coordinate generazionali: se per la popolazione nel suo complesso le fonti tradizionali restano le più affidabili, tra i giovani questa posizione di superiorità non è più scontata. La credibilità non è un’eredità consolidata, ma un bene che richiede una continua legittimazione
La percezione della distorsione informativa
Colpisce la convinzione, ampiamente condivisa, che l’informazione sia in larga misura distorta. Su una scala da uno a sette, dove il primo estremo rappresenta la trasparenza e il secondo la manipolazione intenzionale, gli italiani si collocano mediamente a 4,8, segnalando un orientamento più vicino al sospetto che alla fiducia
Non si tratta di un’impressione vaga o indistinta: molti ritengono che tali distorsioni dipendano soprattutto da pressioni politiche ed economiche, identificate come causa da sei persone su dieci, mentre poco più del 30% attribuisce questi fenomeni a inclinazioni soggettive o personali degli operatori dell’informazione.
A questo si aggiunge il tema della disinformazione. La consapevolezza del problema è altissima: per il 90% degli intervistati la disinformazione rappresenta un rischio serio per la società, eppure solo il 68% percepisce di essere personalmente esposto a episodi di manipolazione o falsificazione dei fatti. Questo divario tra la dimensione collettiva e quella individuale riflette il classico meccanismo psicologico del “succede agli altri, non a me”, che rende più difficile sviluppare consapevolezza critica e contrastare il fenomeno.
Il fact-checking come gesto di autodifesa
In risposta a questa incertezza diffusa, la pratica del fact-checking appare sorprendentemente radicata, almeno nelle intenzioni: il 76% delle persone intervistate dichiara di verificare la veridicità delle notizie con una certa frequenza, anche se spesso attraverso strumenti spontanei e non professionali, come ricerche sui motori di ricerca, confronti tra fonti o discussioni sui social network.