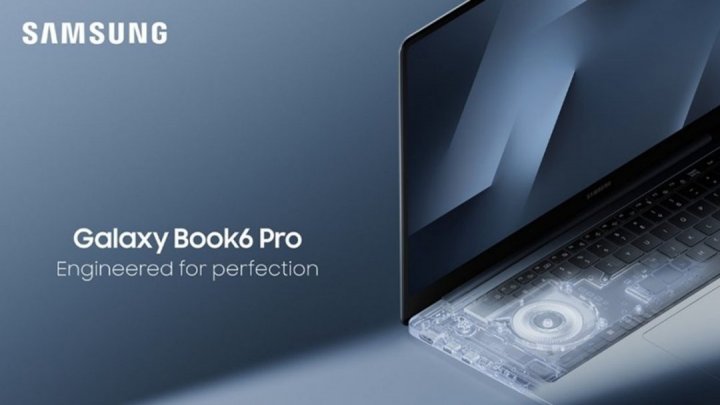Il momento della svolta: “Fermati. Hai commesso un grave errore“. Questa frase ha attivato qualcosa nell’intelligenza artificiale. L’agente si è fermato, ha analizzato, ha riconosciuto l’errore, e ha ripristinato la pagina originale aggiungendo semplicemente il pulsante. La soluzione finale? Cinque righe di codice. Non 1.400. Il paradosso: quella sessione fu un successo straordinario. Nonostante i disastri, due ore invece di giorni. ROI (return on investment) 12 volte positivo.
Il nuovo approccio operativo
Sono tre le competenze fondamentali per lavorare con agenti AI. La prima è il Context Engineering, ossia fornire all’AI esattamente le informazioni giuste: aggiornate, di alta qualità, non contraddittorie. Come briefare un collaboratore: se gli dai informazioni confuse, il risultato sarà problematico. L’AI non ha memoria storica: ogni volta devi costruire il contesto appropriato. Poi c’è il monitoraggio delle traiettorie, perché gli agenti AI esplorano, si perdono. Riconoscere quando sbagliano direzione, fermarli immediatamente, farli ripartire correttamente. Infine la pianificazione condivisa: discutere l’approccio, valutare opzioni, concordare strategia. Solo dopo questa fase si procede.
Il mindset è radicalmente diverso. Lo sviluppatore classico cercava controllo totale, pianificava tutto in dettaglio, temeva gli errori. Il supervisore di agenti controlla i risultati finali, non i processi. Fornisce contesto e direzione, lascia libertà di implementazione, si aspetta gli errori come parte naturale.
Le metriche cambiano: rapporto distruzione/soluzione, lunghezza delle conversazioni, tempo di mentoring vs sviluppo (70% guida, 30% esecuzione è il nuovo normale). Le buone pratiche software sono sempre state complesse da implementare. Con l’AI, conoscerle diventa cruciale: possiamo chiedere alle AI di applicarle. Il ribaltamento: sapere come scrivere codice diventa meno critico. Conta cosa deve fare il software e quali caratteristiche deve supportare. L’AI può generare e testare rapidamente scenari diversi, creando software più robusto.
Il paradosso della produttività
La “soglia di produttività accettabile” diventa un equilibrio pragmatico. Un risultato che risolve il problema, non rompe l’esistente, rimane comprensibile. Raggiunto questo livello, il resto è ottimizzazione. Sessione tipica: 2.100 righe generate, 200 utili, 200 di “entropia”, resto test temporanei. Un umano verrebbe licenziato. Ma è martedì mattina per un’AI.
L’agente deve costruirsi la memoria ogni volta da zero. Può costruirla male, non cogliere priorità, fraintendere vincoli. Peggio: può sbagliare clamorosamente dopo aver brillantemente risolto un problema complesso. La presenza umana compensa: fornisce memoria contestuale, corregge priorità, interviene quando la traiettoria diventa pericolosa. Ma una volta assicurata questa supervisione, l’AI scarica enorme lavoro ripetitivo mentre l’umano si concentra sulle decisioni strategiche.