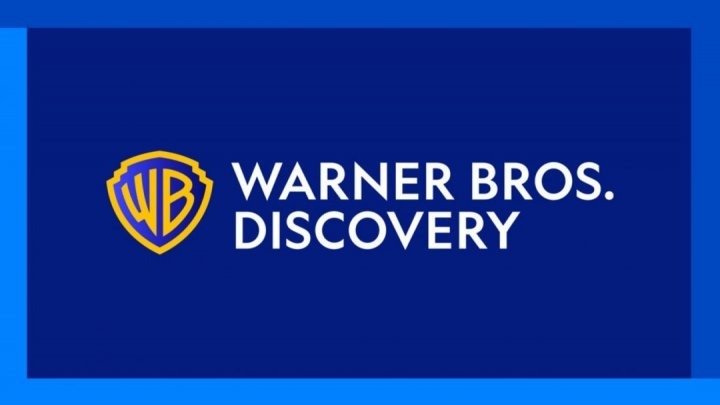Gli alberi usati per realizzare sarcofagi antichi continuano a parlarci, anche dopo millenni. E non c’è niente di macabro. Si tratta di un’applicazione specifica della dendrocronologia, una branca della scienza che studia gli anelli di accrescimento annuale degli alberi, che è alla base di importanti progetti di ricerca cinesi, tra i più vasti al mondo. Obiettivo: ricostruire nel dettaglio la storia ambientale del Paese per contestualizzare le tendenze climatiche e gli eventi estremi (come l’estate da record del 2023) attuali.
Cos’è la dendrocronologia
Dal greco antico déndron (“albero”), chrónos (“tempo”) e lógos (“studio”), la dendrocronologia è la disciplina che si interessa agli anelli di accrescimento degli alberi come metodo di datazione e per ricostruire il clima del passato. Anche di un passato molto distante. Questa branca scientifica si pensa abbia origini antiche e che anche Leonardo da Vinci se ne sia interessato. Il suo sviluppo più sistematico, però, è fatto risalire, a partire dal 1906, all’astronomo statunitense Andrew Ellicott Douglass, che ne dettò i principi.
I tre principi chiave della dendrocronologia
Fin da bambini ci viene spiegato che la vita di un albero è scritta nel legno e che una sezione trasversale del tronco può dirci tante cose. Ogni anno gli alberi che vivono in regioni in cui c’è una netta distinzione tra stagione estiva e invernale producono un nuovo anello di accrescimento, quindi ogni anello rappresenta un anno di vita dell’albero: lo strato più chiaro è il legno primaverile, fatto da cellule più grosse e tondeggianti; lo strato più sottile e scuro è il legno di fine estate/autunnale, composto da cellule di dimensioni inferiori e più piatte.
Un po’ meno noto è il principio di sensibilità al clima: lo spessore degli anelli, infatti, varia a seconda delle condizioni climatiche, in particolare in base alla temperatura e all’umidità. Un anello più spesso indica un’annata di crescita favorevole (piogge abbondanti e clima mite), mentre un anello più sottile indica una crescita rallentata da scarsa disponibilità di acqua o clima più rigido. Ci possono poi essere altri fattori di stress che influenzano la crescita, per esempio una patologia o una potatura.
Un altro caposaldo della dendrocronologia è il cross-dating, il confronto tra sequenze di anelli di alberi della stessa specie vissuti nella stessa area geografica. Prendendo la sequenza di un esemplare di età nota si può risalire all’età dell’altro riconoscendo il pattern simile. Attraverso il confronto di sequenze ricavate da campioni via via sempre più antichi, è possibile costruire curve di riferimento continue che possono risalire indietro nel tempo per centinaia, e talvolta migliaia di anni.
I campi di applicazione
Gli alberi, dunque, sono archivi naturali che memorizzano temperature, precipitazioni e cambiamenti ecologici. Lo studio dei loro anelli pertanto risulta utile in diversi ambiti. In archeologia, per esempio, permette di datare con precisione i manufatti lignei, comprese palafitte e imbarcazioni. La dendrocronologia perfeziona anche le misurazioni ottenute al radiocarbonio, correggendo gli errori dovuti alle oscillazioni di carbonio 14 in atmosfera. Contribuisce ad attribuire all’epoca corretta supporti lignei di opere d’arte, risalendo a quando gli alberi sono stati abbattuti. Ma una delle sue applicazioni principali è in climatologia perché consente di risalire a temperatura, entità delle precipitazioni e anche al livello di certi inquinanti di secoli e addirittura millenni addietro, aiutando a contestualizzare i cambiamenti climatici attuali.
I sarcofagi parlano
All’avanguardia nelle ricerche che si affidano alla dendrocronologia c’è la Cina, un Paese che di recente ha visto aumentare gli studiosi del settore ampliando la conoscenza del suo passato millenario. E a raccontarlo sono i sarcofagi antichi.