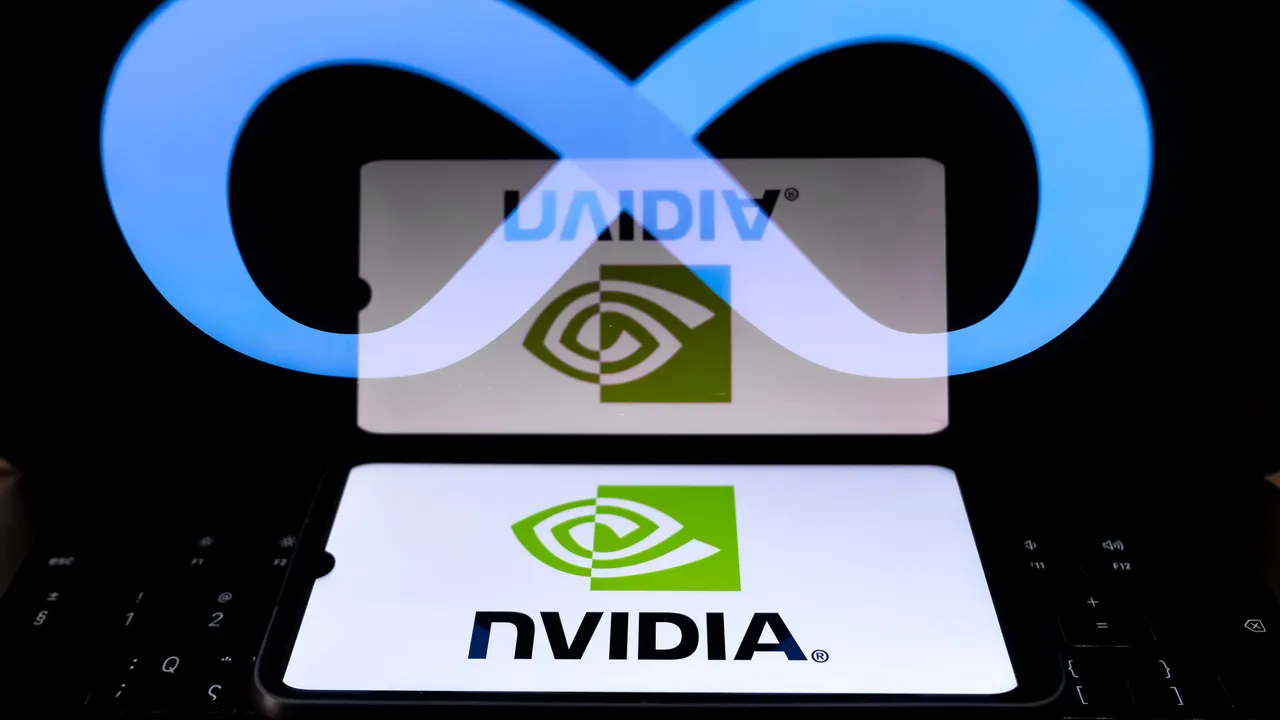Nel linguaggio della diplomazia internazionale, poche espressioni uniscono storia antica e politica contemporanea quanto la tregua olimpica. Ogni volta che si avvicina un’Olimpiade, torna l’idea che il mondo dovrebbe fermarsi almeno per un momento. Ma che cos’è davvero e perché continua a essere evocata?
L’origine antica e la modernità
La sua origine risale all’Antica Grecia, quando, nell’Ottavo secolo, l’ekecheiria garantiva la possibilità di raggiungere Olimpia senza rischiare agguati o violenze. Gli atleti e gli spettatori provenivano da città spesso in conflitto tra loro, e sospendere le ostilità permetteva di partecipare ai Giochi in sicurezza. Non tutte le guerre si fermavano davvero, ma l’istituzione della tregua funzionava come un accordo condiviso, quasi sacro, che proteggeva chi viaggiava per celebrare lo sport.
La versione moderna della tregua olimpica nasce invece negli anni Novanta, quando il Comitato olimpico internazionale ha rilanciato l’idea, in chiave simbolica, cercando di trasformarla in un messaggio universale. Dal 1993 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite approva una risoluzione che invita tutti i Paesi a rispettare la tregua nei sette giorni precedenti l’apertura dei Giochi e nei sette giorni successivi alla chiusura. È un appello formale, non vincolante, ma che porta il peso politico della comunità internazionale. Le Nazioni Unite lo presentano come un invito a garantire l’accesso e la partecipazione sicuri agli atleti e a tutti coloro che lavorano ai Giochi, creando una sorta di corridoio globale protetto.
Ad oggi, la tregua olimpica ha assunto un significato che va oltre la sola sicurezza logistica. Una finestra in cui il mondo è invitato a ricordarsi che esiste un terreno comune anche tra paesi avversari. Il Centro internazionale per la tregua olimpica lavora proprio per diffondere una cultura di pace, usando lo sport come linguaggio universale.
Non mancano però le critiche. Alcuni studiosi considerano la tregua di oggi una tradizione inventata ad arte, sostenendo che il legame con la Grecia che fu sia più simbolico che reale. Secondo altri la tregua non ha forza legale e i conflitti del nostro tempo raramente si fermano davvero durante le Olimpiadi. È il limite più evidente: l’appello dell’Onu può invitare a deporre le armi, ma non può imporlo.
Ma perché, nonostante tutto, continua ad avere senso?
Nonostante questi limiti, la tregua olimpica continua a essere evocata perché rappresenta uno spazio di convergenza, di unione. In un mondo dove i conflitti si consumano in modo sempre più frammentato e perpetuo, l’idea che lo sport possa costringere a fermare le armi come strumento nelle relazioni internazionali, anche solo idealmente, conserva una sua forza. La tregua non promette di cambiare la storia, ma può ricordarci che un’alternativa è possibile, almeno per il tempo di un’Olimpiade.
In vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, la tregua olimpica viene rilanciata come un messaggio concreto di pace. Il 19 novembre l’Italia ha presentato alle Nazioni Unite la richiesta formale di rispettare la tregua per l’intera durata dei Giochi – che si tengono dal 6 al 22 febbraio per le Olimpiadi e dal 6 al 15 marzo per le Paralimpiadi – e l’Assemblea generale dell’Onu ha approvato per consenso la risoluzione proposta dal nostro paese.