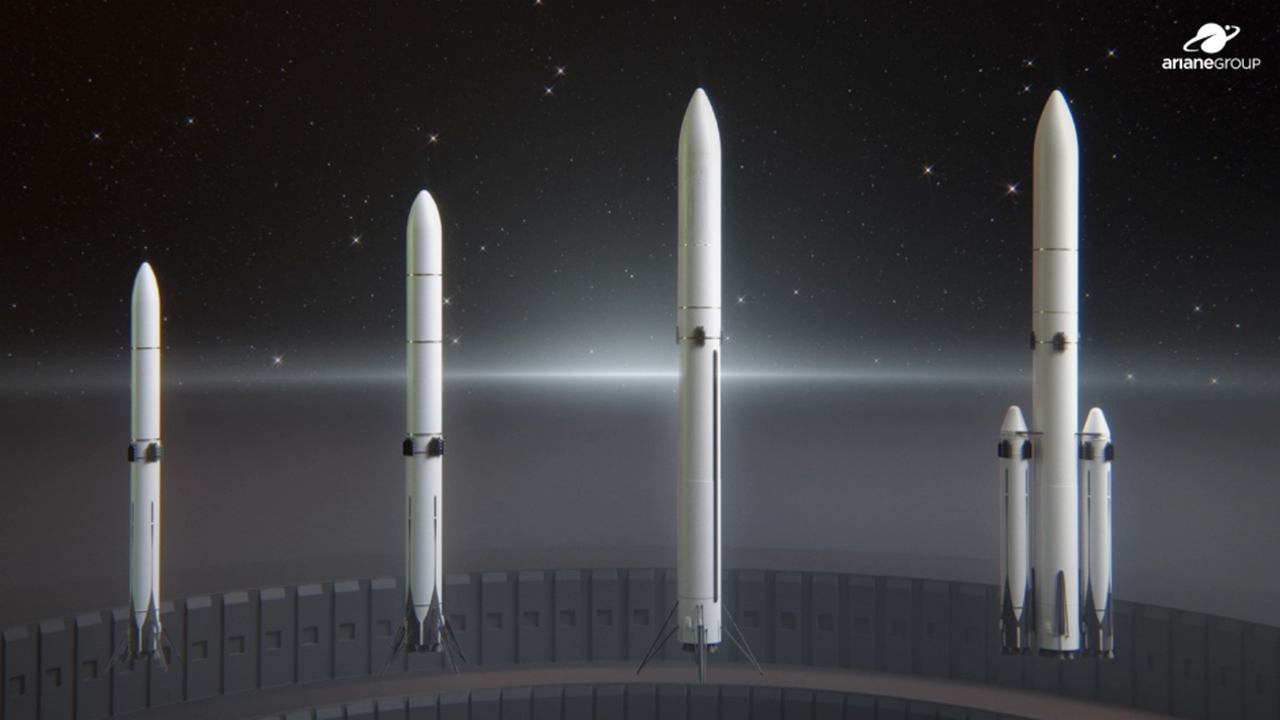“La cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, può essere concessa […] allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno”. Il Regno è quello d’Italia, l’anno era il 1912 e questo è uno stralcio dell’articolo 4 della legge 153 del 30 giugno, per il riordino delle norme sulla cittadinanza, approvata sotto il quarto governo di quel maestro del trasformismo politico che era Giovanni Giolitti. Passano 80 anni e uno degli ultimi atti del settimo governo di un altro grande vecchio della politica nazionale, Giulio Andreotti, è innalzare a dieci anni il tempo di residenza in Italia per ottenere la cittadinanza.
Oggi in Italia è in programma un referendum, l’8 e 9 giugno, che propone di intervenire proprio su quella legge del 1992, la numero 38 del 15 febbraio, e dimezzare i tempi di residenza legale in Italia richiesti alle persone straniere per avanzare la domanda di cittadinanza italiana che sarebbe automaticamente trasmessa a figli e figlie minorenni. Secondo il comitato a sostegno del sì all’abrogazione dei 10 anni, questa modifica sarebbe “una conquista decisiva per la vita” di circa 2,5 milioni di persone che lavorano e risiedono in Italia e per le loro famiglie.
La riforma proposta è un piccolo passo verso la semplificazione del processo di cittadinanza, dato che restano in vigore tutti gli altri criteri, tra cui, per esempio, la conoscenza della lingua italiana, la regolarità del pagamento delle tasse e l’essere incensurati. Insomma, il sì al referendum non porterà certo a regalare la cittadinanza italiana in tutto il globo terracqueo. E di fatto ripristinerebbe un principio di durata che il nostro Paese ha già conosciuto e che è stato stabilito oltre cent’anni fa. E non da un governo di estremisti di sinistra. Il quarto gabinetto Giolitti, che pure approvò l’introduzione del suffragio universale maschile alle elezioni promesso ai socialisti con cui formò il governo, fu quello che diede inizio alla campagna di Libia.
Un pericoloso silenzio
Siccome il referendum di cittadinanza e gli altri quattro quesiti che riguardano il lavoro (e nello specifico quattro norme del Jobs act su licenziamenti, risarcimenti, contratti a termine e sicurezza) sono di natura abrogativa, occorre che alle urne si rechi il 50% più uno delle persone aventi diritto per raggiungere il quorum e considerare la votazione valida. Motivo per cui le forze politiche della maggioranza di governo soffiano sull’invito ad astenersi, come ha fatto esplicitamente il vicepresidente e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, di Forza Italia. Che dovrebbe essere il più moderato della combriccola.
È il segno che a Palazzo Chigi serpeggia il timore che il Paese sia più avanti di chi lo governa (come peraltro ha dimostrato più volte, davanti agli steccati ideologici di molti governi) e pronto a votare sì, specie per il dimezzamento dei tempi sulla cittadinanza. Che, occorre ribadirlo, non sono niente di nuovo sotto il sole dello Stivale. Ora, non bisogna votare sì al referendum perché nel 1912 funzionava così. Questo è solo un aneddoto storico per smontare le millanterie di chi prefigura chissà quale capovolgimento dell’ordine costituito.