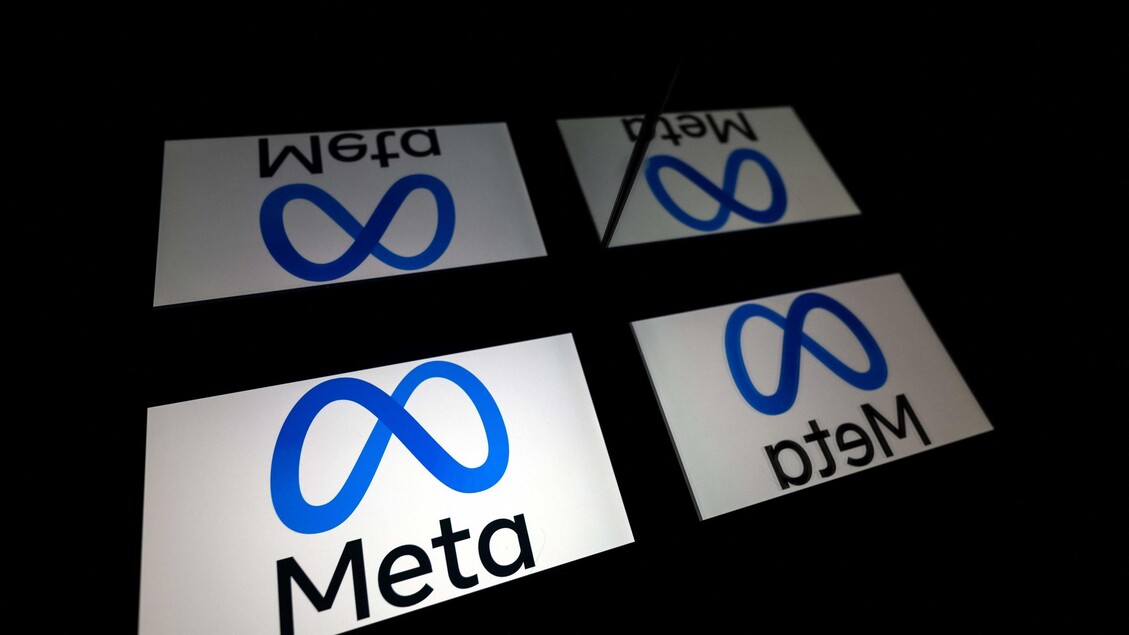È venuto per raccontare come si vive in Israele, da attivista. L’eloquio è lento, puntellato da pause. I gesti nervosi. L’abbigliamento, casual. Una vita in bilico. Nome e cognome siamo costretti a inventarceli. Ragioni di sicurezza: sa di essere un osservato speciale da Tel Aviv. Incontriamo Ariel una mattina d’autunno nel corso di una sua visita in Italia. La storia è quella di un uomo che ha vissuto la propria infanzia in una famiglia di estrema destra e la fase adulta a debita distanza dal suprematismo ebraico da cui proviene. Cresciuto quando trovare informazioni non era facile come ora, nel corso degli anni è diventato una sorta di apolide, scisso tra la tensione atavica verso la propria comunità nazionale e una ragione che fatica a trovare appigli di fronte alle atrocità commesse dal suo governo nella Striscia di Gaza e nei territori occupati della Cisgiordania.
Una persona normale
Niente di più lontano dall’immagine di un rivoluzionario, del militante antagonista caro all’iconografia della contestazione. Piuttosto, un essere umano forse troppo sensibile rispetto al contesto in cui è vissuto, dipinto con la vernice vivida della violenza. Sicuramente, un uomo che non noteresti per strada, Ariel.
“E pensare che da bambino volevo fare il soldato”, ci racconta. “Mi piacevano le armi, i veicoli militari. Capitava che mio padre facesse l’autista per l’esercito, e a volte mi portava con lui. Sin da allora vedevo persone palestinesi portate via l’una fianco all’altra su un camion militare, legate e bendate: chiedevo a mio padre il motivo e lui mi rispondeva che erano arabi. E che sicuramente avevano fatto qualcosa per meritarselo. Dal terrore sui volti era evidente che erano stati minacciati di morte. Eppure, lui lavorava con molti palestinesi, e io ero loro amico. Dopo la scuola, andavo spesso nella città vecchia di Gerusalemme, nel loro quartiere. Per me erano solo esseri umani. E mi capitava di andare spesso con la mia famiglia anche nel luoghi delle colonie, a trovare due zii, entrambi di estrema destra. Gli occupanti, armati, puntavano fucili e pistole sulla gente indifesa e, anche se ero un bambino, mi sembrava chiara la sproporzione in termini di mezzi”.
“Ma in Israele – prosegue Ariel – è normale. Ti crescono nella propaganda: alla radio, in televisione, a scuola. C’è gente che va in vacanza portandosi dietro un paio di fucili. Una mattina, un insegnante entrò in classe parlandoci di un personaggio famoso, un eroe nazionale. Continuava a ripeterci: è bello morire per il paese. Questa era l’ambizione! Io pensavo francamente di no, facevo domande, avevo nove anni e l’idea non mi piaceva. Mi venne risposto di stare zitto, per non finire nei guai. La narrazione che ci veniva propinata tutti i giorni era che gli ebrei fossero in pericolo, ma con l’aiuto di Dio sarebbero riusciti a vincere. Un lavaggio del cervello totale. I palestinesi? Dobbiamo ucciderli tutti, bombardarli, cancellarli dalla faccia della Terra. Ed è quello che stanno facendo ora”.
Un processo interiore lungo per arrivare al cambiamento
Così chiediamo a Ariel cosa lo abbiamo allontanato da quella mentalità, come sia riuscito a cambiare: “Non è stata un’illuminazione, si è trattato di un processo lento. Vedevo la gente che lavorava con mio padre umiliata tutti i giorni, fermata ai checkpoint quando veniva a lavorare a Gerusalemme. Osservavo e mi rendevo conto che non avevano i nostri stessi diritti. Mio nonno era un sopravvissuto all’Olocausto e ce ne parlava spesso, soprattutto a me che ero il primo nipote. Ho idea che prendesse queste sevizie come una specie di vendetta. Il confronto tra quello che aveva passato lui e quello che passavano i palestinesi mi tormentava. Così cercai più informazioni. Avevo quindici anni nel 1987, ai tempi della prima intifada. Allora non c’era internet. Andai alla biblioteca nazionale. E con mia grande sorpresa scoprii che, nonostante quello che ci avevano insegnato, su quella terra noi non c’eravamo da sempre. Ho trovato delle mappe che mostravano l’evoluzione della popolazione cristiana, musulmana ed ebraica, ed è stato scioccante. Ho dovuto controllare diverse volte per essere sicuro di aver capito bene. Uscii di là dicendomi: ‘Sono parte di un peccato, quello che accade è qualcosa di troppo malvagio’. Ho cominciato a sentirmi in colpa con tutti i palestinesi che conoscevo. Ma, anche a scuola, era meglio stare zitti, non dare nell’occhio. Figuriamoci nell’esercito. Le donne sono obbligate a fare due anni di leva, gli uomini tre. E la prima cosa che ti chiedono ai colloqui di lavoro è: dove hai servito?”.