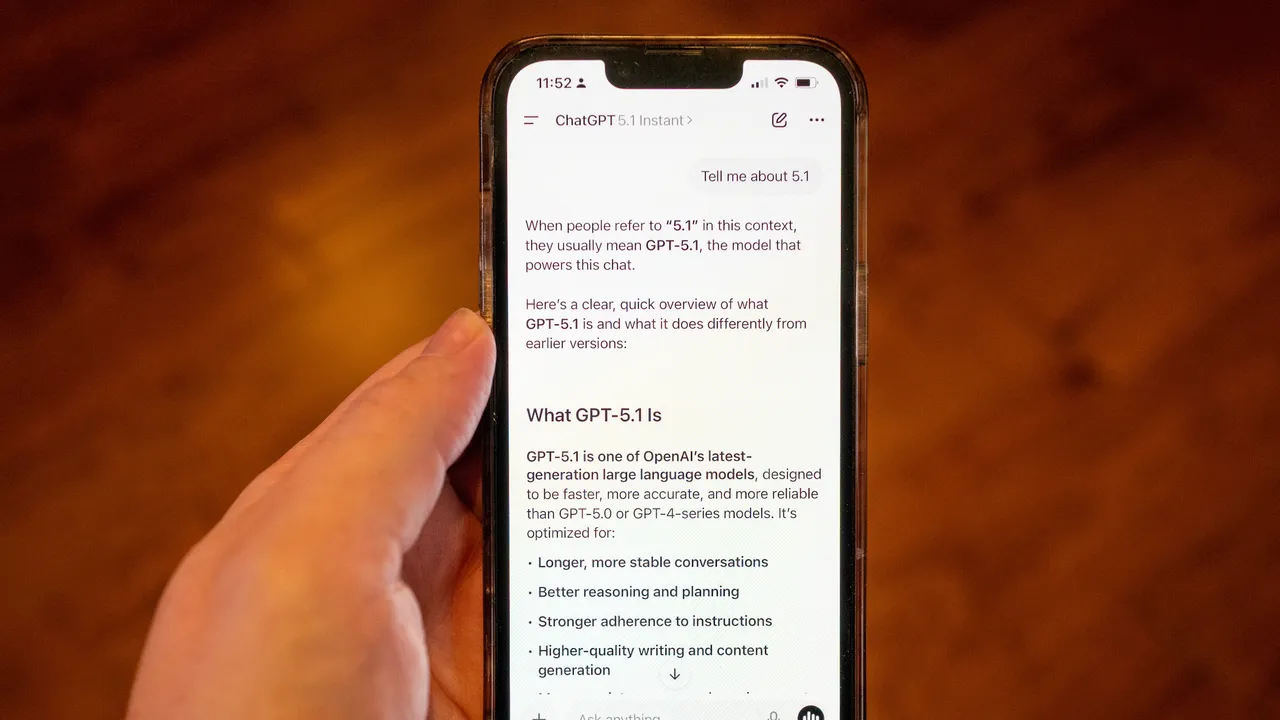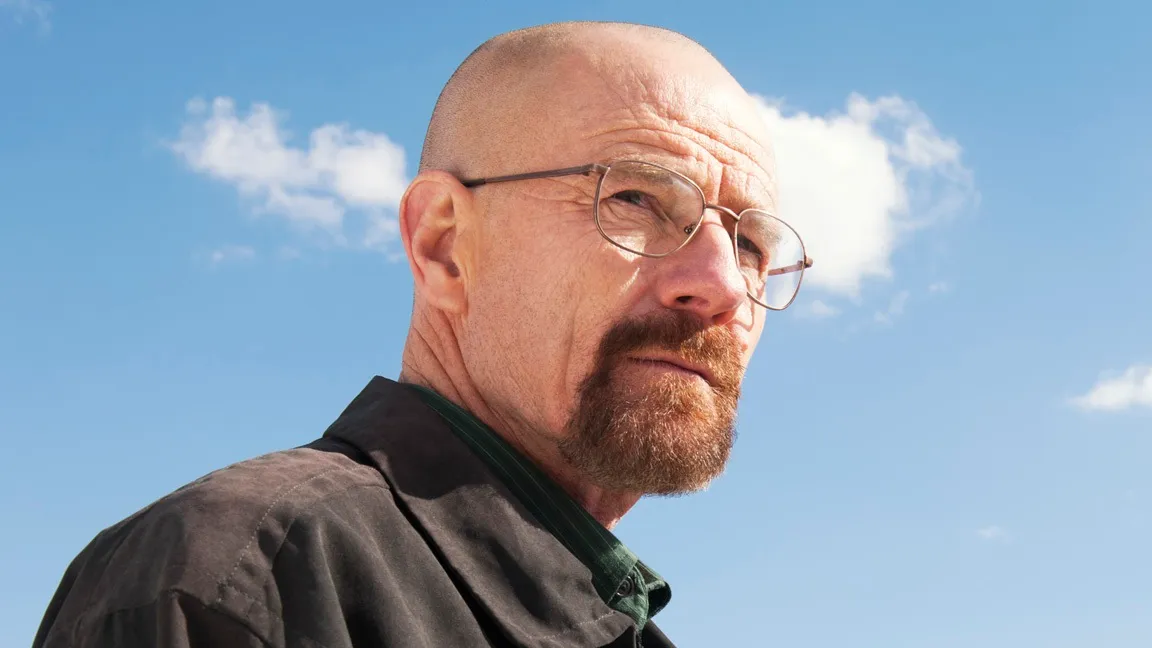Fisica dei tuffi: dagli agilissimi tuffatori olimpici alle improvvisazioni balneari sulle spiagge italiane, il tuffo in piscina rimane il re delle attività estive. Ma qual è il segreto—scientifico—dietro allo splash perfetto? Non parliamo solo dei tuffi controllati e silenziosi valutati dalle giurie olimpiche, ma anche di quelli che danno il massimo spettacolo, per esempio nello stile Manu jump che recentemente dalla Nuova Zelanda ha conquistato anche l’interesse la comunità scientifica internazionale (ci arriveremo tra un attimo). Il tuffo, in effetti, è prima di tutto un affare scientifico, fatto di regole (anche) controintuitive su come generare la colonna d’acqua più alta e rumorosa (e fastidiosa) e di nuovi studi che hanno coinvolto la fluidodinamica avanzata e addirittura l’utilizzo di robot subacquei. Vediamo di capirci qualcosa in più.
La fisica dei tuffi, dal trampolino alla caduta libera
Il primo passo per comprendere la fisica dei tuffi è descrivere il movimento del corpo in caduta libera. Che siate su un trampolino olimpionico o a bordo piscina, scendete accelerando per effetto della gravità: la velocità raggiunta dipende solo dall’altezza del salto e dalla costante gravitazionale terrestre. Un tuffatore che salta da 10 metri, per esempio, raggiunge circa 50km/h in appena 1,43 secondi: a queste velocità, la collisione con l’acqua può essere sorprendentemente “dura”, se la superficie d’impatto è estesa (come nel doloroso belly flop, o più volgarmente panciata), oppure sorprendentemente morbida se impattiamo con una piccola area, come fanno i professionisti entrando “a candela”.
L’arte maori del Manu, ovvero quando la fisica dà spettacolo
La vera “chicca”, però, è quella che viene dal Manu jump, una tradizione delle comunità Māori e Pasifika in Nuova Zelanda, recentemente oggetto di uno studio pubblicato sulla rivista Interface Focus. Il perfetto Manu jump, in particolare, consiste in quattro fasi cruciali: una rincorsa con manovre aeree che portano il corpo in posizione a V (cioè con le gambe e il busto che formano un angolo di circa 45°); un ingresso in acqua “di sedere”; un rapido movimento subacqueo in cui il tuffatore si “espande”, ruotando e scalciando sott’acqua per inglobare quanta più area possibile; il conseguente collasso della cavità d’aria (pinch-off), che sprigiona (finalmente!) il getto verticale d’acqua detto Worthington jet, responsabile del vero spettacolo. Nel loro studio, i ricercatori hanno scoperto che il fattore cruciale è l’angolo di ingresso in acqua: la posizione a V è infatti quella che equilibra al meglio la creazione di una cavità d’aria ampia ma profonda, il che amplifica la potenza del getto finale mantenendo, al contempo, margini di sicurezza per il tuffatore.