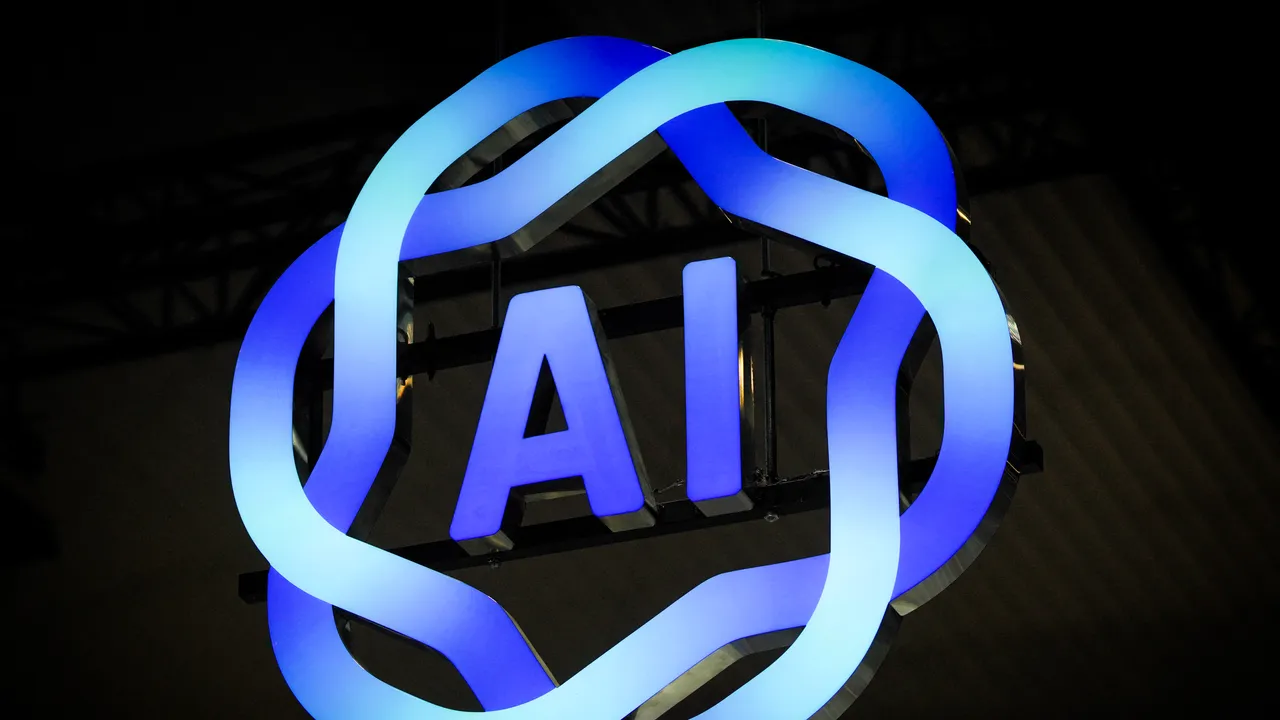Homeschooling, unschooling, istruzione parentale: negli ultimi giorni queste tre parole, finora confinate a forum specializzati, hanno invaso il dibattito pubblico. Se ne discute senza sapere bene cosa significhino, e quasi sempre mescolandole al caso della famiglia Trevillion-Birmingham, il caso di cronaca dei cosiddetti “bimbi del bosco” allontanati dal nucleo familiare dopo una segnalazione sanitaria.
Il risultato è stato un cortocircuito: la questione educativa, che è chiaramente normata e tutt’altro che ambigua, è stata confusa con un provvedimento che riguarda invece tutt’altro, ossia la tutela dei minori rispetto alle condizioni di vita. Per capire cosa è successo (e cosa no), bisogna prima rimettere in ordine i pezzi.
Istruzione parentale: la cornice italiana e costituzionale
In Italia il termine corretto non è homeschooling ma istruzione parentale e non è né una zona grigia, né un gesto di ribellione verso lo Stato, bensì un diritto sancito dall’articolo 30 della Costituzione, che riconosce ai genitori la libertà di provvedere direttamente all’istruzione dei propri figli. Una famiglia può decidere di non iscrivere il minore a scuola e di occuparsi autonomamente del suo percorso educativo. Il punto è che questa libertà non è assoluta: è regolata. Ogni anno i genitori devono comunicarlo al dirigente scolastico del territorio, devono dimostrare di avere “mezzi e capacità” adeguate e il bambino deve sostenere un esame di idoneità per attestare che stia raggiungendo gli obiettivi previsti dal percorso scolastico nazionale. È un sistema che combina autonomia familiare e garanzie pubbliche e funziona in modo piuttosto lineare.
Questo approccio è stato ribadito anche dalla Corte di cassazione, con una sentenza depositata il 4 agosto 2023 (04/08/2023, n. 23802), che oggi torna d’attualità. La Corte scrive in modo inequivocabile che la scelta dell’istruzione parentale è “pienamente legittima”, espressione del diritto-dovere dei genitori, e che eventuali interventi limitativi della responsabilità genitoriale sono ammessi solo quando esiste “un rischio di pregiudizio per il minore”, rischio che “non può derivare dalla sola scelta dell’istruzione parentale”. In sintesi: educare i figli fuori dalla scuola non può essere considerato un pericolo di per sé.
Homeschooling è il termine che usiamo, ma che non c’è nella legge
Quando sui social si parla di homeschooling si intende genericamente “fare scuola a casa”. Ma in Italia, però, homeschooling non è un termine normativo: è un’etichetta culturale, presa dal mondo anglosassone, che copre qualsiasi forma di educazione domestica. La disciplina reale è l’istruzione parentale: è lì che si collocano obblighi, controlli e verifiche.
Questa differenza semantica, che può sembrare marginale, è parte della confusione attuale: molte persone, e anche alcune figure politiche, utilizzano “homeschooling” per indicare qualsiasi forma non scolastica di istruzione, senza rendersi conto che la legge italiana ha un profilo molto preciso – e non particolarmente permissivo – per chi sceglie questa strada.
Unschooling: l’approccio più radicale (e il più frainteso)
Tra homeschooling e istruzione parentale spesso compare un terzo termine: unschooling. È una filosofia educativa nata negli Stati Uniti d’America, che si basa sull’apprendimento spontaneo e auto-diretto del bambino. Niente programmi scolastici, niente materie, niente valutazioni strutturate: solo curiosità, esplorazione quotidiana e tempo libero trasformato in conoscenza.