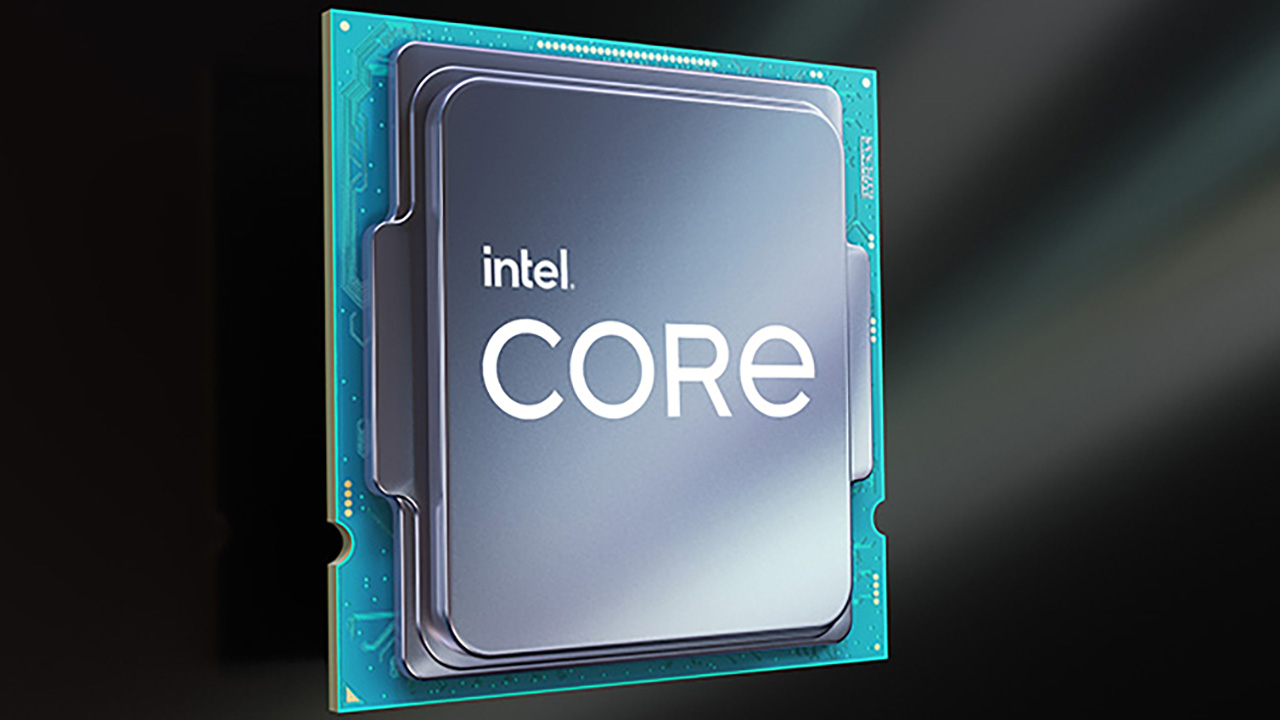Intorno a un buco nero l’ambiente estremo è dinamico e in continua evoluzione. A testimoniarlo sono le nuove e dettagliate immagini del buco nero supermassiccio al centro della galassia M87, chiamato M87*, che rivelano appunto come l’ambiente che lo circonda sia dinamico, con configurazioni di polarizzazione variabili, e per la prima volta mostrano emissioni a 230 GHz vicino alla base del suo getto. Ad analizzare oggi le osservazioni svolte dall’Event Horizon Telescope è stata la collaborazione internazionale, che comprende i ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e dell’Università Federico II di Napoli, secondo cui questi risultati forniscono preziose informazioni su come materia ed energia si comportino vicino ai buchi neri, aumentando la nostra comprensione sul loro ruolo nell’evoluzione cosmica. Il loro studio è stato pubblicato su Astronomy & Astrophysics.
L’osservazione del buco nero
Il buco nero M87*
Ricordiamo brevemente che il buco nero M87* si trova a circa 55 milioni di anni luce dalla Terra e ha una massa di oltre 6 miliardi di volte quella della nostra stella. Sappiamo, inoltre, che i getti come quello del buco nero M87* giocano un ruolo fondamentale nell’evoluzione delle galassie, regolano la formazione delle stelle e distribuiscono energia su vaste scale. La sua emissione in tutto lo spettro elettromagnetico, inclusi raggi gamma e neutrini, rappresenta quindi un laboratorio unico per studiare come questi fenomeni cosmici si formino e vengano generati.
La polarizzazione invertita
La prima fotografia del buco nero M87* è stata scattata nel 2019 dall’Eht e oggi grazie alle osservazioni condotte nel 2017, 2018 e 2021, sappiamo qualcosa in più su come i campi magnetici vicino al buco nero cambiano nel tempo. In particolare, tra il 2017 e il 2021, la configurazione di polarizzazione ha invertito direzione: nel 2017 i campi magnetici sembravano avvolgersi in un senso, nel 2018 si erano stabilizzati, mentre nel 2021 si sono invertiti, avvolgendosi quindi nel senso opposto rispetto a quanto osservato negli anni precedenti. Alcune di queste variazioni, come ipotizzano i ricercatori, potrebbero essere influenzate non solo dalla struttura magnetica interna, ma anche da effetti esterni, come la presenza di un plasma magnetizzato che agisce da “schermo di Faraday”, una sorta di patina di gas magnetizzato che altera il segnale luminoso prima che raggiunga i telescopi.