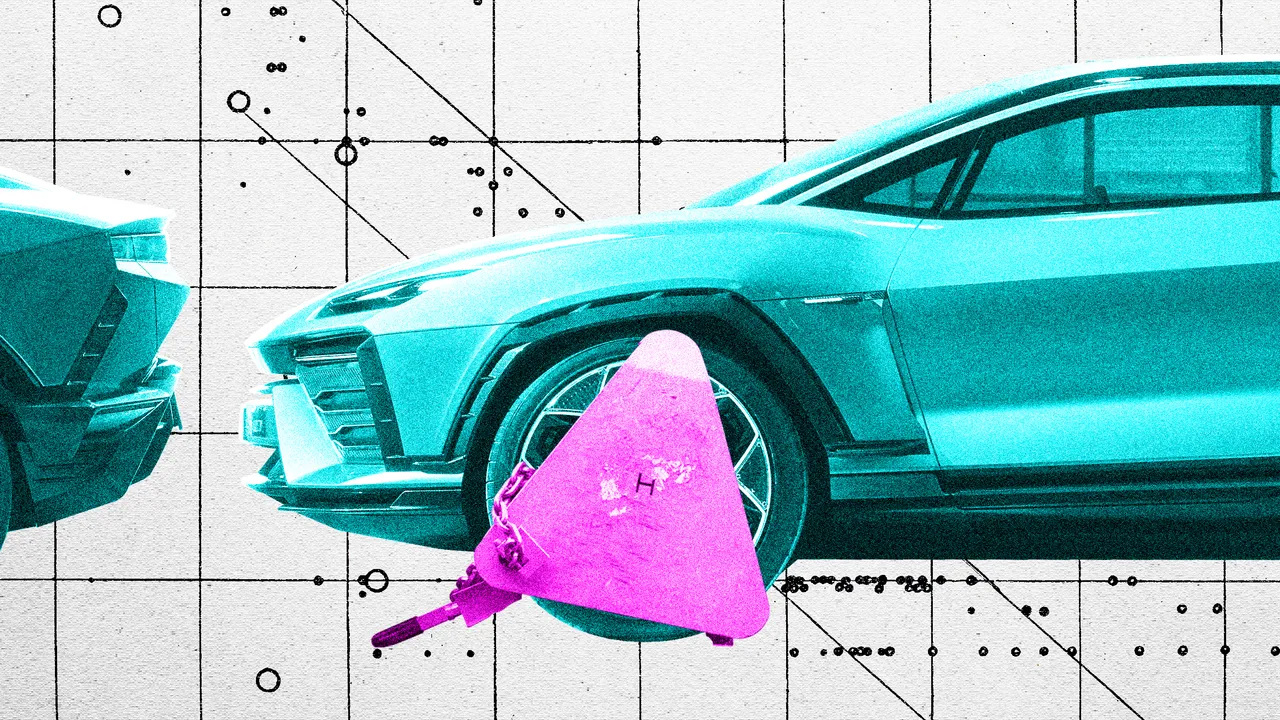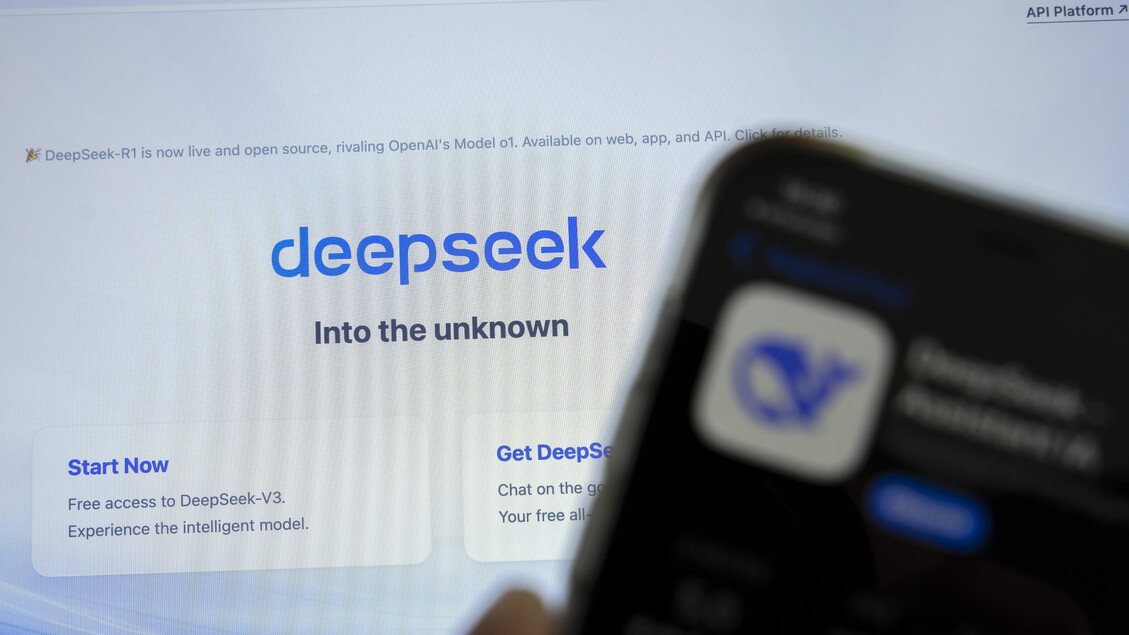La decisione di abbandonare il settore fu dettata dalla convenienza economica delle importazioni e dai costi crescenti dell’estrazione locale, ma oggi quella scelta si rivela strategicamente problematica. L’ultimo grande progetto minerario, la miniera di zinco di Gorno in Lombardia, chiuse nel 1982 dopo decenni di attività, simbolo di un’industria che l’Italia scelse deliberatamente di dismettere.
Dove si cerca cosa
Il programma attuale per l’esplorazione di miniere in Italia prevede indagini concentrate nelle stesse aree che quarant’anni fa si rivelarono economicamente insostenibili. In Sardegna si cercheranno tungsteno, terre rare e rame nel distretto di Funtana Raminosa, mentre nel Centro Italia l’attenzione sarà rivolta al litio in contesti geotermali e sedimentari. Per ora, però, si eviteranno scavi e perforazioni per limitare l’impatto ambientale e le opposizioni locali, affidandosi invece a tecniche di rilevamento a distanza come la radiografia muonica – che usa particelle provenienti dallo spazio per osservare il sottosuolo senza danneggiarlo – e a sistemi di intelligenza artificiale per analizzare le immagini satellitari.
Solo in una fase successiva, e previa autorizzazione ambientale, si passerà a indagini dirette. I dati raccolti durante la prima fase confluiranno nel database nazionale GeMMA, una mappa digitale delle risorse minerarie italiane finanziata dal Pnrr e pensata per essere consultata da ricercatori e investitori. Parallelamente, il progetto Urbes investirà 10 milioni di euro per catalogare le discariche di scarti minerari sparse nel paese, nella speranza che le tecnologie attuali permettano di estrarre materiali preziosi che in passato non era possibile recuperare.
I colli di bottiglia che frenano l’Europa
Il piano europeo per riconquistare una parziale autonomia mineraria è molto ambizioso, soprattutto considerando che l’Europa è un continente che dal dopoguerra ha progressivamente abbandonato quasi tutte le attività estrattive ritenute poco redditizie, oltre che dannose per l’ambiente e per le comunità locali. Non sorprende, quindi, che la maggior parte dei progetti avviati negli ultimi anni, in vari paesi, abbiano incontrato forti opposizioni: in Serbia, le proteste contro il progetto di Rio Tinto nella valle di Jadar hanno costretto il governo a bloccarlo, mentre in Portogallo le contestazioni contro il progetto Barroso proseguono da oltre due anni.
Oltre alle resistenze locali, pesa anche il nodo dei tempi di sviluppo, spesso incompatibili con gli obiettivi politici. Secondo le analisi di settore, servono in media dai 7 ai 15 anni per passare dalla scoperta di un giacimento all’entrata in funzione di una filiera produttiva completa, inclusi gli impianti di raffinazione, un percorso che nelle democrazie occidentali risulta ancora più lento a causa dei vincoli ambientali e delle lungaggini burocratiche. Nel frattempo, la domanda di litio è destinata a crescere di diciotto volte entro il 2030, ma anche i progetti più avanzati faticano a rispettare le tempistiche: in Germania, Vulcan energy resources ha più volte posticipato l’avvio dell’estrazione da salamoie geotermiche, mentre in Austria il progetto Wolfsberg di european lithium è ancora fermo alla fase di finanziamento.
Da parte sua il governo italiano ha tentato di accelerare i processi prevedendo licenze estrattive da rilasciare entro 18 mesi e procedure semplificate per i progetti strategici, inclusa la possibilità di ottenere permessi di esplorazione senza valutazione di impatto ambientale. Questa scelta ha suscitato immediate critiche da parte delle associazioni ambientaliste, che denunciano un abbassamento degli standard di protezione. Secondo Friends of the earth, l’apertura di nuove miniere in Europa non diminuirà i problemi delle miniere extra-UE, ma aumenterà semplicemente il numero di progetti estrattivi a livello globale.
La contraddizione più evidente emerge dal confronto tra obiettivi e risorse. I 3,5 milioni di euro stanziati per la prima fase di esplorazione appaiono modesti se confrontati con gli investimenti necessari per sviluppare progetti minerari competitivi. L’esperienza internazionale indica che servono centinaia di milioni di euro per portare una miniera dalla fase esplorativa alla produzione commerciale, cifre che l’Italia dovrà trovare in un contesto di bilanci pubblici sotto pressione.